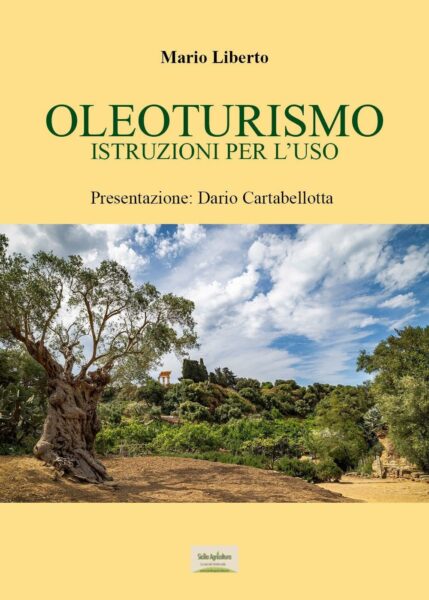Nella primavera del 1971, inviato dal settimanale Tempo, Luciano Bianciardi venne in Sicilia.
Nella primavera del 1971, inviato dal settimanale Tempo, Luciano Bianciardi venne in Sicilia.
Accompagnato dal fotografo Federico Patellani, Bianciardi realizzò un lungo reportage (che uscì nel numero del 29 maggio, con il titolo Viaggio attraverso la paura) che iniziava con l’annotazione della varietà dei paesaggi isolani, tra ‘la sontuosa piana catanese, che sembrava la terra promessa per l’abbondanza dei frutti sugli alberi’(‘avevamo rubacchiato persino qualche limone e qualche mandarino’) e ‘i monti brulli e sassosi come il deserto della Tebaide’ attraversati per raggiungere, sulle orme di Verga, Vizzini; poi Bianciardi passava subito a scrivere dell’arrivo a Palermo che gli ‘parve una città fuori dal tempo, cadente, disabbandonata, con i cornicioni, i rosoni e le lesene che crollavano giù dai palazzi, e nessuno badava a raccattare, a rattoppare, a rimettere in sesto’.
Una Palermo raggiunta dopo aver dato uno sguardo agli alloggi dei terremotati di Calatafimi, Castelvetrano e Santa Ninfa, dove la sorpresa per le ‘baracche diventate la dimora eterna della gente’ afflitta dalla calamità naturale, diventa rabbia nel vedere la stessa gente ‘credersi garantita in eterno dalla pena di una casa murata’, e vederla , quella gente sostanzialmente inerte, incapace di rimettere in sesto la vita precedente; di fronte al desolante spettacolo di distruzione materiale e morale, Bianciardi si chiede: ‘come mai i terremotati non distruggono le case dei ricchi?’ e la risposta è: ‘ci deve essere una specie di ingiustizia naturale, che fa i poveri sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi.
 Già, appunto, la mafia.’ Ed è per capirne di più, sulla mafia, che Bianciardi si reca ad ascoltare un testimone d’eccezione: ‘siamo andati subito a cercare, naturalmente, Leonardo Sciascia, che sta di casa nei quartieri nuovi di Palermo. Ci siamo poi visti in una sontuosa libreria della capitale, e quindi in un dovizioso caffé li vicino. Sciascia ci guardava con i suoi occhi acuti e vivi di isolano, abbastanza ironici per il nostro impaccio di ‘continentali’ grossi e spaiati’. Conversando con Sciascia, Bianciardi si sente contestare la sua visione della mafia come organizzazione che permea la società siciliana laddove è assente lo Stato, sostituendovisi ed esercitando la forza e il dominio; lo scrittore di Recalmuto gli dice che quella è la visione del continentale, ‘dell’italiano medio’ e gli fa notare che la mafia è cambiata ed ‘opera in grande a Palermo, nei quartieri alti, specula sugli immobili e sui mercati generali, sta a Roma, dove è entrata nel governo e nel sottogoverno’.
Già, appunto, la mafia.’ Ed è per capirne di più, sulla mafia, che Bianciardi si reca ad ascoltare un testimone d’eccezione: ‘siamo andati subito a cercare, naturalmente, Leonardo Sciascia, che sta di casa nei quartieri nuovi di Palermo. Ci siamo poi visti in una sontuosa libreria della capitale, e quindi in un dovizioso caffé li vicino. Sciascia ci guardava con i suoi occhi acuti e vivi di isolano, abbastanza ironici per il nostro impaccio di ‘continentali’ grossi e spaiati’. Conversando con Sciascia, Bianciardi si sente contestare la sua visione della mafia come organizzazione che permea la società siciliana laddove è assente lo Stato, sostituendovisi ed esercitando la forza e il dominio; lo scrittore di Recalmuto gli dice che quella è la visione del continentale, ‘dell’italiano medio’ e gli fa notare che la mafia è cambiata ed ‘opera in grande a Palermo, nei quartieri alti, specula sugli immobili e sui mercati generali, sta a Roma, dove è entrata nel governo e nel sottogoverno’.
Da Palermo, in direzione dei luoghi ‘della mafia che ha le sue origini e le sue radici in questa parte di Sicilia’, Bianciardi muove verso le montagne di Gibilrossa (e i suoi ricordi vanno alle avventure storiche che ha sempre prediletto, quelle risorgimentali e garibaldine, perché proprio a Gibilrossa ‘si adunarono i ‘picciotti’ di La Masa e i Mille polentoni di Garibaldi’) e di Montelepre, dove una sosta forzata davanti al cimitero cittadino, causata da un guasto alla macchina, gli permette una passeggiata per i viali del camposanto e la scoperta della fastosa tomba di Salvatore Giuliano ‘che sembra il sarcofago di un imperatore romano’ e a ‘tre isolati cimiteriali di distanza’ quella del cugino Gaspare Pisciotta.
E nel paese di Giuliano gli ritornano in mente le parole che gli aveva detto, molto tempo prima, Danilo Dolci (‘a Partinico la vita di un uomo costa meno che altrove’) e le impressioni ancora vivide della sosta a Palma di Montechiaro: ‘Viene da piangere, se si va in visita a Palma di Montechiaro, seguendo con la fantasia la memoria di Donnafugata e del Gattopardo. Sì, c’è una ‘trattoria del Gattopardo’ e c’è anche un cartello turistico pronto a informarti che il duomo di Donnafugata è lì davanti a cinquanta passi, mentre il palazzo di Lampedusa, del principe santo, sta di dietro, sempre a cinquanta passi. I1 guaio è che cinquanta passi a sinistra, proprio sotto il palazzo del principe santo, la gente di Palma va a fare di corpo e lo sterco si è ormai accumulato. Il guaio è che la maggior parte delle strade sono fangaie, le case pericolano e hai la sensazione che nessuno abbia voglia di muovere un dito’.
 Infine Bianciardi (dopo un passaggio a Portella della Ginestra, nei campi pietrosi e brulli dove vi fu l’eccidio) arriva a Corleone: il paese gli appare come ‘il più tragico che abbia mai incontrato’. Gli sembra posto ‘in naturale stato d’assedio’. ‘Su tre lati incombono, a dirupo, le rocce grigie e giallastre’ – descrive Bianciardi – ‘il terzo lato è la valle di un torrentaccio limoso, e noi siamo lassù, sullo strapiombo, a guardare, oltre la roccia grigia e gialla, oltre le case grigie e gialle, il cumulo del pattume che il paese ha vomitato durante chissà da quanti anni: persino i cingoli di un carro armato americano son rimasti là sopra, residui delle Seconda guerra mondiale’. Plumbeo gli appare il paesaggio, ancora antica la vita: ‘Passano vacche scure e stente, passano uomini vestiti di nero in groppa a un asino o a un mulo, non passano ragazze. Già, mi sono accorto che in questa parte di Sicilia il sesso non è mai esibito: persino i manifesti pubblicitari, che altrove si appellano sempre a un richiamo di tipo sessuale, anche per convincerti a comprare un’aranciata o una motocicletta, qui non esistono. È facile immaginare che esista una vita sessuale (quanti saranno mai i bambini che sciamano sul fango delle strade?), eppure non esiste l’esibizione del sesso. Le sole donne che vedi in giro sono le nonne, sempre a lutto.
Infine Bianciardi (dopo un passaggio a Portella della Ginestra, nei campi pietrosi e brulli dove vi fu l’eccidio) arriva a Corleone: il paese gli appare come ‘il più tragico che abbia mai incontrato’. Gli sembra posto ‘in naturale stato d’assedio’. ‘Su tre lati incombono, a dirupo, le rocce grigie e giallastre’ – descrive Bianciardi – ‘il terzo lato è la valle di un torrentaccio limoso, e noi siamo lassù, sullo strapiombo, a guardare, oltre la roccia grigia e gialla, oltre le case grigie e gialle, il cumulo del pattume che il paese ha vomitato durante chissà da quanti anni: persino i cingoli di un carro armato americano son rimasti là sopra, residui delle Seconda guerra mondiale’. Plumbeo gli appare il paesaggio, ancora antica la vita: ‘Passano vacche scure e stente, passano uomini vestiti di nero in groppa a un asino o a un mulo, non passano ragazze. Già, mi sono accorto che in questa parte di Sicilia il sesso non è mai esibito: persino i manifesti pubblicitari, che altrove si appellano sempre a un richiamo di tipo sessuale, anche per convincerti a comprare un’aranciata o una motocicletta, qui non esistono. È facile immaginare che esista una vita sessuale (quanti saranno mai i bambini che sciamano sul fango delle strade?), eppure non esiste l’esibizione del sesso. Le sole donne che vedi in giro sono le nonne, sempre a lutto.
Ne abbiamo conosciuta una che veste di nero dal 1925, e ci ha spiegato il perché: il lutto dura ogni volta due anni, e lo si fa anche per i parenti lontani, e siccome i parenti son molti, può succedere anche che una persona stia a lutto tutta la vita. La brava donnetta confida nel luglio del ’71, quando scadranno gli ultimi suoi due anni di lutto: poi butterà giù nel pattume il suo vestito nero e se ne metterà uno sgargiante, a fiori’.
Per di più, a pranzo, all’interno di un ristorante del paese, tra la diffidenza generale, qualcuno sottovoce mormora, in direzione di Bianciardi e dei suoi accompagnatori: ‘sono italiani’.
Un viaggio, quello dell’autore de La vita agra, contrassegnato dall’amarezza per le condizioni dell’isola e dal ‘magone’ che gli provoca la visione di tanta incuria (‘questa terra è stata abbandonata dalla sua classe dirigente’), e che al contempo gli fa ripensare con simpatia e stima ai tanti siciliani che ha conosciuto (‘desti, attenti, coltissimi’). E di tanti che erano emigrati dalla Sicilia, Bianciardi aveva raccontato, specialmente nelle cronache degli anni cinquanta: di quelli che aveva visto al lavoro, da sfruttati, nelle miniere toscane di Ribolla; degli insegnanti che animavano le discussioni serali nei bar di Grosseto e che venivano tacciati come ‘terroni’ chiamati a insegnare nelle città del Nord perché ‘appartenenti ad una mafia che riesce a controllare i posti chiave, anche nei provveditorati agli studi’; dei giornalisti sportivi, incontrati negli stadi, che ‘stavano zitti e facevano gli indifferenti’, ma dai ‘baffetti, dagli occhi mobili e vivaci, dalle basette un po’ lunghe si capiva l’origine’.